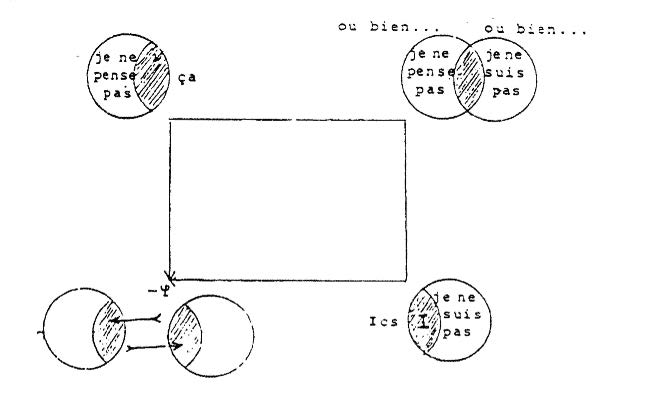
06 Feb L’Es e l’Inconscio nella logica del fantasma di Lacan
Il rapporto del Pensiero con l’Essere, nel tradizionale processo della conoscenza,
poggiando sull’ipotesi illusoria della corrispondenza tra microcosmo e macrocosmo,
conduce, in un miraggio di perfezione, all’idea totalizzante dell’Uno.
Il passo decisivo di Cartesio, che sostituisce a questo rapporto del Pensiero con
l’Essere la pura instaurazione dell’essere dell’Io, si limita al semplice impianto del
“sum”.
Ciò implica il puro funzionamento del soggetto del “cogito”, che può avere
l’apparenza di essere trasparente a se stesso, ma che, nel suo statuto di semplice suispensée,
non ha niente a che vedere con quella che abitualmente viene detta
“coscienza di sé” e situa il soggetto soltanto nel punto in cui non può che articolare:
“penso”.
Ora se è vero che il passo di Cartesio è preparato dal rigetto di tutto il sapere,
percorrendo cioè a ritroso il duro cammino che nel processo della conoscenza
condurrebbe dal Pensiero all’Essere, è anche vero che a questo passo è essenziale la
dimensione dell’Altro.
In un ragionamento per induzione totale l’Altro viene condotto per mano, lungo il
cammino della rinuncia a tutte le vie del sapere, con l’intento di cogliere di sorpresa
questo Altro, per chiedere e ottenerne a una svolta la confessione che almeno per
quello, per il fatto cioè di avergli fatto percorrere questo cammino, questo Io, bisogna
che sia.
È vero che Cartesio spinge poi questo Altro fino all’essenza divina, e già nelle
“Regulae” il “sum ergo Deus est” è esattamente il prolungamento del “cogito ergo
sum”; ma qui è unicamente nell’ “ergo”, nel “dunque”, cioè soltanto nella semplice
articolazione logica, che l’Altro è da noi colto come pura referenza della parola a
sostegno del “sum”.
D’altra parte questo Altro, divenuto inevitabilmente il Garante divino del “cogito
ergo sum”, è segnato da Cartesio dalla marca dell’inganno.
In questo tratto di un Dio che al limite può anche ingannare, Lacan scorge la
referenza inconfondibile del significante, che in quanto tale è del registro della
menzogna: è lo statuto del “tratto unario”.
Resta tuttavia l’ombra che se il “cogito ergo sum” non si completa col “sum ergo
Deus est”, come articolazione filosofica non è tenibile; ma balugina per noi anche la
luce di un beneficio: aver limitato l’Essere al piccolo margine del “sono”, inerente al
soggetto del “penso” come tale.
Nella nuova prospettiva di Cartesio tuttavia la funzione del Garante, se lo è di una
Verità che, se Dio lo vuole, può anche essere l’errore, con una virata esemplare, tutta
la questione sulle verità eterne è lasciata dal filosofo a questo Dio ed è ridotta
semplicemente a specificarsi come quella funzione che assicura la verità di tutto ciò
che si articola come tale.
Proprio qui Lacan individua la funzione idealizzante dell’Uno, il “tratto unario”
dell’identificazione.
La funzione strutturante dell’Ideale dell’Io, come punto concreto
dell’identificazione inaugurale del soggetto, non potrebbe avere formalizzazione più
rigorosa; ma pur risultando insostituibile all’economia del soggetto nell’atto della sua
instaurazione, la funzione dell’Ideale dell’Io si rivela presto provvisoria e, alla lunga,
fuorviante. Essa trova infatti il suo punto di arresto nel miraggio dell’Io-ideale.
Nello stesso Cartesio per esempio la distinzione di una “res cogitans” da una “res
extensa” esilia il pensiero dalla “estensione” e lo riporta ad una dimensione realista.
Dal semplice tratto di struttura, dall’ “unario”, si rischia di far ritorno all’Uno
dell’idealismo.
È qui che si innesta l’apporto di Freud che trova nell’inconscio l’origine del
pensiero.
La “res cogitans” nell’esperienza freudiana risulta marcata alle radici e si impone
per la sua caratteristica spezzettata e spezzettante: la si ritrova si può dire sparpagliata
nelle cose.
La lezione freudiana ci porta a ristabilire l’Altro nella sola funzione che gli
compete, quella di luogo della parola, luogo cioè in cui l’asserzione si pone come
veridica.
Che l’Altro non ha alcuna specie di esistenza al di fuori di questo luogo Lacan lo
scrive con l’algoritmo S(A/) [con la barra sulla A]; tagliando corto con quella
“mitologia grossolana” che, in nome di una “non si sa quale nostalgia di una unità
primitiva, d’un puro e semplice battito della soddisfazione”, lo vuole assimilato a
qualcosa che rappresenta l’Altro di un rapporto nutritivo, o peggio ancora, “confonde
quest’Altro nutritivo con l’altro sessuale” (Logique du fantasme 18-1-67. Seminario
inedito).
Lacan trova che l’unico modo di situare il “cogito” di Cartesio è quello di
collocarlo sotto la rubrica di ciò ch’egli articola come “alienazione”: quella “forma di
scelta forzata…verso un’alternativa che si salda con una mancanza essenziale..”.
È una modalità originale elaborata da Lacan per mettere al riparo il “cogito”
dall’esigenza del Garante che la chiamata in causa dell’Altro implica. La mancanza è
il posto lasciato vuoto dalla barra sul Garante. L’esito della mancanza vuol dire che la
scelta forzata viene dal soggetto dell’enunciazione, la cui esistenza è assicurata dalla
negazione.
Si tratta di quella negazione non riducibile alla forma del misconoscimento
articolata nell’enunciato, perché anteriore a tutto ciò che risulta articolato; allorché,
per esempio, “non desidero” non implichi in modo complementare qualcosa che non
desidero e nemmeno che non sia io a desiderare, ma piuttosto verta sul: “non è vero”
che desidero.
Si tratta dunque di quella negazione radicale che riconduce alla questione stessa
del soggetto, al suo punto di sospensione di fronte allo statuto di Verità, che
logicamente lo precede.
Se la scelta forzata dell’alienazione è di questo momento logico che precede ogni
enunciato, nel regime cioè della negazione radicale, il ”cogito” ne risulta marcato e
insieme con esso l’Altro.
La marca ristabilisce l’Altro al solo statuto di luogo della parola, cioè di “luogo in cui
l’asserzione si pone come veridica”, e nello stesso momento lo destituisce da
qualsiasi altro tipo di esistenza.
Ma poiché dirlo, precisa Lacan, è ancora fare appello a lui per situare questa
verità, è come farlo risorgere ogni volta che parlo, allora “ – che l’Altro non ha
alcuna specie d’esistenza – non posso dirlo ma posso scriverlo. Ed è per questo che
scrivo S, significante dell’A grande barrata, come costituente uno dei punti nodali di
questa rete, attorno al quale si articola tutta la dialettica del desiderio, in quanto essa
si scava nell’intervallo tra l’enunciato e l’enunciazione” (Logique du fantasme, cit.).
Il limite e il superamento del “cogito” è formalizzato da Lacan con l’inserzione
della asserzione cartesiana in un rapporto proposizionale, dove la negazione della
congiunzione, secondo l’enunciato di De Morgan ripreso da Boile si traduce nella
negazione dell’intersezione: ~(A.B) º (~AV~B).
Dalla semplice negazione della riunione di A e B ne risulta cioè o la negazione di
A o la negazione di B: dalla semplice negazione della riunione di “cogito”e “sum” ne
risulta: ou je ne pense pas ou je ne suis pas, “o io non penso o io non sono”.
La formula così tradotta rende ancora più evidente la portata di ciò che Cartesio
introduce.
Il “cogito” è il punto culminante di un processo di svuotamento del pensiero e di
evitamento dell’essere.
L’insieme vuoto dell’uno è correlativo all’insieme vuoto dell’altro, nella
instaurazione di un Io (je) che non corrisponde ad alcun elemento né dell’uno né
dell’altro; di un Io che, nella maniera più succinta, corrisponde al puro ed unico
fondamento dell’essere.
Il passo di Cartesio è dunque possibile soltanto al culmine di un processo marcato
dalla negazione, per porre quest’Io, questo je, come pura instaurazione dell’essere.
Abbiamo visto come, secondo l’enunciato di De Morgan, la marca della
negazione traduca la semplice congiunzione in una alternativa: “o io non penso o io
non sono” (ou je ne pense pas ou je ne suis pas).
La pura instaurazione dell’Io, del je, comporta questa alternativa. Così Lacan
legge Cartesio.
La cosa sorprendente è che, posti di fronte ad essa, non abbiamo scelta, siamo
obbligati a tendere verso il primo dei suoi termini, “io non penso”, se vogliamo
preservare l’Io (je); ma poiché si tratta di un’alternativa, il risultato di questa scelta
non può che essere una perdita, la perdita dell’altro termine “io non sono”, in cui
consiste quell’Io (je) per il quale tutta l’operazione è stata fatta.
Per valutare gli effetti della perdita conseguente alla scelta, che abbiamo visto
obbligata, Lacan raffigura l’alternativa con due cerchi alla Eulero che si intersecano;
che mordono cioè l’uno sull’altro, ritagliando un campo d’intersezione. Questo
campo corrisponde all’”ergo” del “cogito” originario.
Connessa alla scelta del je ne pense pas la caduta del je ne suis pas non è senza
conseguenze: una sbrecciatura si produce nel campo dell’intersezione, nel luogo dell’
“ergo”; dove appare qualcosa che si sostenta di essere “non-io”, pas-je, e che tuttavia
conserva i connotati dell’ “ergo”, cioè della pura struttura logica.
Si tratta di ciò che Freud, nella seconda topica, chiama “Es”, e che Lacan
introduce a questo punto della sua elaborazione per darne la definizione più rigorosa:
“Le ça, l’Es è…nel discorso, in quanto struttura logica, esattamente tutto ciò che non
è je, cioè a dire tutto il resto della struttura. E quando dico struttura logica intendete
grammaticale” (Logique du fantasme, 11-1-67 ). Qui Lacan legge Freud (“Pulsioni e
loro vicissitudini”, 1915) e alla lettera, affermando che questa struttura grammaticale
è il supporto della pulsione.
Se la struttura grammaticale è l’essenza dell’ “Es” ( ça ), il “fantasma” è una
sceneggiatura; cosa che Lacan altre volte ha illustrato con il sogno dell’uomo dei lupi
e che qui sintetizza dicendo che il “fantasma” potrebbe esprimersi così: Ein Kind ist
wird geschlagen, “un bambino è picchiato”. Sta qui il crinale, la linea spartiacque tra
ciò che insegna Lacan a partire da Freud e ogni lettura oscurantista di Freud: il
funzionamento della pulsione è un montaggio grammaticale.
La struttura della frase “un bambino è picchiato” esclude la presenza dell’Io;
nell’analisi che ne fa Freud il soggetto non arriva mai a confessarsi. Solo nel tempo
dell’interpretazione si giunge alla “Bedeutung”, alla significazione che sia lui a
essere battuto; ma l’enunciato del “fantasma” come tale è ciò che resta della struttura
grammaticale: il “senso” cioè nel quale il soggetto si aliena al costo del suo essere,
dell’Io che va perduto. Ogni frase insensata ha il suo senso purchè abbia una sua
struttura grammaticale: Colourless green ideas sleep furiously.
Con la pulsione siamo al livello del senso; ma “la verità dell’alienazione non si
mostra che nella parte perduta, in quell’altro termine della scelta forzata: “io non
sono”.
L’essenza dell’inconscio non sta nella pulsione ma nella dimensione dell’io non
sono.
Lo dimostra l’effetto di sorpresa che si manifesta a livello di ogni vera interpretazione.
La sorpresa è connessa alla fenomenologia dell’io non sono, che è la vera essenza
di ogni formazione dell’inconscio. Nel motto di spirito “è al livello di questo je ne
suis pas che si produce il riso”. Quando il callista e ricevitore del lotto HIRSCH
HYACINTHE assicura di essere stato trattato dal barone SALOMON ROTSCHILD con modi
del tutto “familionari” è della inesistenza della posizione del ricco che ragiona, in
quanto non è altro che finzione; ma al tempo stesso ciò che egli dice lo mette nella
stessa situazione di inesistenza, perché vi è ridotto egli stesso a una specie di essere
per il quale non c’è posto da nessuna parte. Se al livello dello “Es” (ça), di pura
struttura grammaticale, abbiamo l’effetto di Sinn, di senso; qui al contrario abbiamo a
che fare con la Bedeutung. Mentre l’effetto di senso viene in derivazione di una
scelta: obbligata, alienante, ma pur sempre una scelta, la Bedeutung si produce
all’insaputa perché viene dal fondo di una mancanza d’essere.
Se il ça, l’“Es”, è ciò che viene al posto di quella sbrecciatura in cui il pensiero è
morso dal disessere, l’inconscio è ciò che si forma in quel luogo del disessere,
sbrecciato dall’esclusione del je ne pense pas ; dove l’Io del “non penso” si rovescia
e si aliena in un “penso” che non è Io, in un “penso cose”.
È ciò che Freud dice dell’inconscio, ch’esso è costituito dalle rappresentazioni di
cose, Sachvorstellugen.
Questo “penso” che non è Io, sorto nel luogo del disessere, l’inconscio, non va
riunito, come si tende a fare, con ciò che resta della struttura grammaticale escluso
l’Io, con l’“Es” (ça): l’”Es” e l’inconscio non si ricoprono.
Penso cose, non sono io che penso: nel sogno, per esempio, l’Io, l’Ich, l’“ego”, è
disperso tra tutti i pensieri che lo costituiscono ad opera dei diversi meccanismi
dell’inconscio, Verdichtung e Verschiebung. In tal modo questi pensieri che
costituiscono il sogno sono ridotti allo statuto di segni; di guisa che ciascuna delle
“cose”, Sache, robe, cose occasionali, giocano le une in rapporto alle altre una
funzione di rinvio tale che ci fa smarrire come in un mondo disordinato.
Sennonché Freud c’insegna nella Traumdeutung all’inizio del capitolo VI, “Il
lavoro del sogno”, ciò che Lacan avrebbe espresso con la formula che “l’inconscio è
strutturato come un linguaggio”: “…il contenuto del sogno è dato tutto come in una
scrittura fatta d’immagini (geroglifici) i cui segni sono da tradurre solamente nella
lingua dei pensieri del sogno”.
Allo stesso modo nel “Rebus” le immagini che lo costituiscono sono “cose” –
spesso inverosimili come una barca su una casa o un uomo che corre con una virgola
al posto della testa – “cose” che valgono come segni in rapporto a una Bedeutung, a
una significazione regolata da una logica speciale che applica le leggi della scrittura.
Per semplificare: la struttura grammaticale del discorso comune, priva dell’Io (je),
costituisce l’“Es” (ça) e perviene al senso; mentre il je, l’ich lo troviamo disperso
nelle “cose”, Sachen, a costituire il “penso-cose” dell’inconscio; il quale è regolato da
una logica sua, che possiamo assimilare a quella della scrittura; ma non c’è scriba,
non c’è demiurgo.
Il ça (l’Es) e l’Inconscio non sono sovrapponibili, non sono coestensivi, non
direttamente, essi piuttosto, in un quarto tempo, vanno a sovrapporsi ai loro correlati:
ciascuno al correlato dell’altro, in un modo che possiamo rendere visibile, se
facciamo scorrere i due cerchi l’uno verso l’altro, di modo che si eclissino e si
occultino a vicenda.
In questo “tempo ulteriore”, “termine quadrico”, “il ça verrà al posto del je ne
suis pas, positivandolo, beninteso, in un je suis ça (io sono questo Es)”: “è il puro
imperativo della formula wo es war, soll Ich werden”. Imperativo proprio alla
struttura del masochismo, altrettanto impraticabile del “dovere” kantiano; dove l’Io
(je), proprio perché non c’è, è chiamato a prendere posto nella logica dell’ “Es” (ça).
Ma propriamente è l’“Es” che, in questo 4° tempo, viene nel luogo del disessere dove
è svelata la verità della sua struttura: l’oggetto piccolo a.
Di converso, nell’altra occultazione di questo quarto tempo, “l’inconscio”, nella
sua essenza poetica e di “Bedeutung”, viene al posto dell’ “io non penso”, subendo il
colpo della caducità propria al pensiero, con un buco nella significazione.
Questa sincope della “Bedeutung” è illustrata da Lacan con la lacuna del sogno:
quella rottura nel racconto del sognatore che Freud riconduce al testo stesso del
sogno, come parte integrante di esso.
Il testo preso in esame è ancora del capitolo 6°, “Il lavoro del sogno”, della
“Interpretazione dei sogni” (pag. 306 dell’ed. italiana): “Vado con la signorina K. al
ristorante dei giardini pubblici…poi viene un punto oscuro, un’interruzione… poi mi
trovo nella sala di un postribolo dove vedo due o tre donne, una delle quali in camicia
e mutandine”. Segue l’analisi di Freud: “La signorina K. è la figlia del suo ex
superiore e, come egli stesso ammette, un sostituto della sorella.
Solo di rado ha avuto occasione di parlare con lei, ma una volta ci fu tra loro una
conversazione in cui “in un certo qual modo prendemmo coscienza del nostro sesso,
come se dicesse: io sono un uomo e tu una donna”.
“Ecco perché, precisa Lacan, Fraulein K. viene scelta per l’esordio del sogno,
nonché senza dubbio, per provocare la sincope. Ciò che segue viene infatti a turbare
questo bel rapporto di consapevolezza tra l’uomo e la donna. Le tre persone che per
lui sono legate al ricordo del ristorante e che rappresentano anche quelle che incontra
nella sala del postribolo sono sua sorella, la moglie di suo cognato e un’amica
dell’una e dell’altra, poco importa, perché in ogni caso tre donne con le quali aveva
dei rapporti di cui non si può dire che fossero caratterizzati da un approccio sessuale
franco e diretto”.
Tre persone dunque apparentemente indifferenti sul profilo sessuale ma
certamente accomunate dal significante “sorella”.
L’interpretazione si basò sul “punto oscuro”, sulla “interruzione” nel sogno e
stabilì che per curiosità infantile egli aveva qualche volta esaminato, ma solo di rado,
l’organo genitale della sorella, minore di alcuni anni. Solo di rado, come pure
soltanto di rado, forse due o tre volte nella vita, il sognatore ha visitato un postribolo.
Qualche giorno dopo si presentò il ricordo cosciente del misfatto cui il sogno
alludeva.
Altrimenti detto quando nel lavoro del sogno, Trauminhalt, viene abbordato
qualcosa che nel linguaggio metterebbe in causa ciò che ne è dei rapporti del sesso, si
produce una sincope.
Il senso logico originale della castrazione per Lacan sta nel fatto che, a livello di
significazioni, Bedeutungen, il linguaggio fa difetto e riduce la polarità sessuale ad
avere o non avere la connotazione fallica.
L’assunzione di questa verità, da parte del soggetto umano, è possibile soltanto
rinnovando su un altro piano la funzione dell’alienazione, la funzione cioè dell’Altro
barrato.
Dalla semplice alienazione logica del je ne pense pas, per effetto dell’analisi, è
possibile pervenire “alla rilettura della stessa necessità alienante nella Bedeutung dei
pensieri inconsci”; con un risultato differente nei due casi.
Il risultato della prima operazione l’abbaiamo visto: un soggetto limitato alla pura
struttura grammaticale e specialmente sottomesso alle due pulsioni scopofiliaca e
sadomasochista, quel soggetto di pura funzione grammaticale che facendo il giro
attorno alla mancanza avvertita nell’Altro vi insedia l’oggetto che deve colmarla. In
questo egli si crede je, Io del discorso; mentre ciò che evidentemente attiva il
funzionamento è l’oggetto stesso, al quale dunque si riduce il soggetto in questa fase.
Tutto ciò per difendersi dalla verità che gli viene dalla prima alienazione, la
marcatura dell’Altro per effetto dell’ “io non penso”; verità che dal soggetto è
assimilata all’orrore provato da bambino di fronte alla castrazione della madre.
Così la sessualità tale e quale è vissuta e opera in questo ambito è qualche cosa
che rappresenta un difendersi dal dare seguito alla verità che non c’è Altro. Nel
tentativo sempre rinnovato di reintegrare, in un falso pensiero di fusione, l’Unità con
la madre, l’atto sessuale è il significante di questa ripetizione.
Ciò che è avvertito come mancanza a livello della scelta alienante e che mette in
moto il montaggio grammaticale della pulsione (1° tempo), deve essere realizzato
come perdita nella Bedeutung dei pensieri inconsci (4° tempo). Soltanto con la
manovra analitica, l’oggetto piccolo a può passare dallo statuto della mancanza a
quello della perdita.
La difficoltà della manovra sta nel fatto che il senso viene sempre invocato a
colmare il punto di “sincope della Bedeutung”. Tutto ciò che attiene all’oggetto
piccolo a si manifesta sotto l’aspetto di Bedeutung tappata, di significazione
rattoppata.
Colourless green ideas-sleep furiously: “Sfido chiunque -dice Lacan- a dare un
supporto qualunque all’espressione “bel seno”. I due componenti, che nel corpo
femminile concorrono a giustificare quell’espressione, “dormono furiosamente”.
“Niente, mi sembra, può meglio esprimere in modo più adeguato… Ch’essi dormono,
furiosamente all’occasione e che per svegliarli non è impresa da poco”. Ecco il senso.
L’impatto con ciò che vi è di anestesico in certe parti attraenti del corpo,
corrisponde al limite ottuso della frase a senso; perché “è proprio in questa parte
anestesica del corpo che dimora il godimento” (Logique du fantasme, 14-6-1967).
Luigi Burzotta


